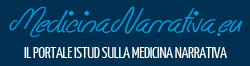“Autenticità” deriva dal latino tardo authentĭcus, a sua volta dal greco authéntikos, che nasce da authéntēs, “colui che agisce da sé”, formato da autós (“sé stesso”) ed éntos (“dentro”). Essere autentici significa quindi agire a partire da sé, dall’interno, senza contraffazioni. Non è un’imitazione: è qualcosa di genuino, che scaturisce dalla propria verità interiore.
Trasportata nel campo della medicina narrativa, questa parola assume una forza speciale. L’autenticità nelle storie dei pazienti non è legata alla precisione dei dettagli, ma alla capacità di dare voce a ciò che si prova, a come la malattia viene vissuta. Il racconto autentico non è una cronaca sterile, ma un atto di verità: un modo per tradurre in parole ciò che abita dentro.
Eppure, l’autenticità è una parola delicata. Non basta che una persona racconti: serve che il suo racconto venga riconosciuto come significativo, non sminuito, non ridotto a “errore” o “fraintendimento”. Qui la medicina narrativa ci insegna che autenticità significa reciprocità: un ascolto che non giudica, ma che prova a comprendere l’altro dal suo punto di vista.

Questa prospettiva trova un’eco interessante nella riflessione filosofica sul consenso informato. James Stacey Taylor ha recentemente mostrato che l’autonomia di una persona non è necessariamente compromessa da false credenze o da ignoranza. Un paziente può restare autonomo anche se non conosce tutti i dettagli tecnici. Ciò che invece viene compromesso è la possibilità di dare un consenso autentico. Se credo che una biopsia sia un semplice “tubo in gola” e non un’incisione, il mio “sì” non è realmente un consenso, perché manca l’allineamento tra ciò che penso e ciò che accade.
Ecco allora che autenticità diventa ponte tra narrazione e consenso. Un racconto autentico del paziente può contenere errori scientifici, ma resta prezioso perché esprime la sua esperienza. Un consenso autentico, invece, richiede che le informazioni date e ricevute trovino una corrispondenza di senso. In entrambi i casi, ciò che è in gioco è la fiducia: fiducia che la mia voce venga ascoltata, fiducia che le informazioni fornite siano comprensibili, fiducia che le mie scelte siano rispettate.
Per questo, parlare di autenticità in medicina narrativa significa anche interrogarsi sul ruolo dei professionisti: come creare spazi dove il paziente possa narrare senza sentirsi giudicato? Come tradurre i termini tecnici in un linguaggio che non perda precisione ma sia accessibile? Come restituire alle persone la sensazione che il loro consenso non sia una firma burocratica, ma un atto di partecipazione consapevole alla cura?
Autenticità non è mai perfetta: è un orizzonte, una tensione continua. Ma proprio per questo è così centrale in medicina narrativa. Ci ricorda che curare non è solo applicare protocolli, ma accompagnare storie. E che, tra le tante firme sui moduli e le tante parole annotate nelle cartelle cliniche, ciò che conta davvero è che i pazienti possano dire: “Sono stato ascoltato, ho potuto scegliere. Sono stato autenticamente me stesso, anche nella malattia”.
Bibliografia:
- https://www.treccani.it/vocabolario/autenticita/
- Taylor JS. Informed Consent, Autonomy, False Beliefs, and Ignorance. Social Philosophy and Policy. 2024;41(2):546-564. doi:10.1017/S0265052524000244