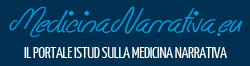Negli ultimi anni, dopo aver pubblicato un libro sull’uso dei testi letterari come fonte di conforto (Literature and Consolation– Edinburgh University Press, 2021), mi sono occupato di un’ampia gamma di argomenti che ricadono sotto l’ombrello molto ampio della “biblioterapia”, ovvero l’uso di libri e altri materiali di lettura narrativa a scopi di benessere. Nel Regno Unito, il termine è sempre più utilizzato per indicare una pratica in cui persone che si definiscono biblioterapisti (in modo non ufficialmente legittimato; quindi, non è una professione che implica una laurea, anche se ciò non significa che non sia legittima) prescrivono specifici materiali di lettura agli individui. L’anno scorso, due di queste persone hanno pubblicato un libro, intitolato in entrambi i casi Biblioterapia, in cui spiegano i principi fondamentali di questa pratica e danno una serie di suggerimenti di lettura relativi a specifici problemi esistenziali o di crisi: Bijal Shah, Bibliotherapy. The Healing Power of Reading (Piatkus, 2024) e Molly Masters, Bibliotherapy Books to Guide You through Every Chapter of Life (Harper Collins, 2024).
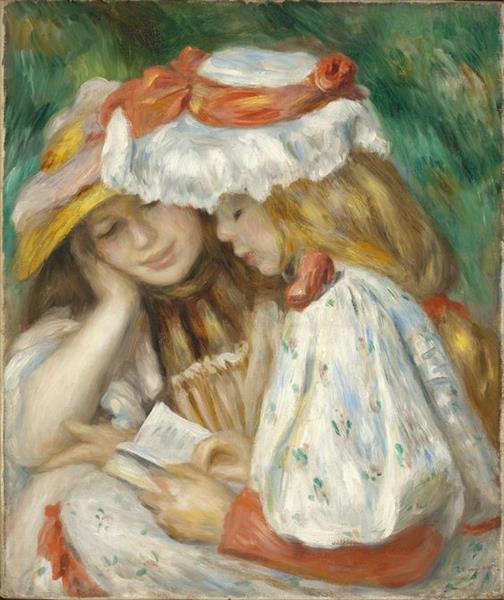
Il fulcro di questa pratica sembra essere la convinzione che, se un libro specifico è stato “salutare” per un lettore, è destinato a esserlo anche per altri lettori, proprio come ci si aspetta che i normali prodotti medicinali funzionino per gruppi di persone piuttosto che per singoli individui. Una versione estrema di questa idea si trova in The Novel Cure (La cura del romanzo) di Ella Berthoud e Susan Elderkin, un libro del 2013 precursore di questi libri più recenti, che si presenta nel suo sottotitolo come una “A-Z of Literary Remedies” (una sorta di “A-Z dei rimedi letterari”). La premessa di ognuna delle 400 prescrizioni letterarie e dei suggerimenti di lettura che compongono questo volume di 450 pagine è la stessa: se avete questo o quel problema (crepacuore, crisi di mezza età, essere dei santarellini), allora la lettura di questo libro farà al caso vostro. In altre parole, il lettore non viene trattato come un individuo con un problema individuale in un contesto individuale, ma come una persona generica, un caso intercambiabile. Per continuare la metafora medica, si potrebbe dire che la lettura di un libro in questo tipo di biblioterapia è molto simile all’assunzione di un farmaco: un atto abbastanza passivo, che richiede solo di essere inghiottito, per così dire.
La mia idea di biblioterapia (una pratica che definirei “cura letteraria” piuttosto che terapia vera e propria) parte da una premessa diversa, esemplificata in un altro libro che si intitola “biblioterapia”, ma che è stato pubblicato originariamente in francese nel 1994: il suo autore, il filosofo e rabbino francese Marc-Alain Ouaknin, attinge a piene mani dall’ermeneutica esistenziale di Paul Ricoeur, in cui la lettura non è vista solo come un atto di co-creazione, ma anche come un atto che impegna e riguarda l’identità individuale di chi legge. In effetti, la pratica della lettura ha un impatto fondamentale su questa identità individuale: la lettura rende più consapevoli di chi si è e di chi si sta diventando, e lo fa invitando a pensare a sé stessi in relazione al libro che si sta leggendo e ai personaggi che popolano il suo mondo. Inoltre, il libro non è visto come la soluzione a un problema o a una determinata crisi, ma come un compagno in un processo continuo di sviluppo personale e quindi individuale che permette di essere meglio attrezzati per affrontare i problemi e le crisi una volta che si presentano. Se vogliamo proseguire con la metafora medica, direi che si tratta più di un caso di medicina preventiva che di medicina curativa vera e propria. È più una questione di assistenza che di cura.
La lettura condivisa è un metodo sviluppato nell’ambito della The Reader Organisation, un’associazione di beneficenza con sede a Liverpool fondata nel 2008 (in pratica dal 1997) dalla studiosa di letteratura britannica Jane Davis, che voleva trasmettere ad altre persone la forza della lettura di testi letterari che lei stessa aveva sperimentato quando da giovane, provenendo da un contesto di povertà, aveva sentito per la prima volta l’impatto positivo e avvolgente della lettura di narrativa sulla sua immagine di sé. Questo impatto è difficile da cogliere nella sua interezza, ma può essere descritto, credo, con una serie di termini che sono confermati dalla ricerca empirica sulla pratica della lettura condivisa: l’empowerment sarebbe uno di questi (l’idea che gli scritti letterari abbiano fornito alla giovane Jane Davis dei modelli da utilizzare per affrontare le circostanze difficili in modo da rafforzare la sua resilienza), la solidarietà (la consapevolezza di non essere soli a combattere quelle circostanze difficili, che anche altri lo hanno fatto e con successo), ma anche il multi prospettivismo, la consapevolezza che non c’è un solo modo di vedere il reale, che le prospettive degli altri possono mostrare modi diversi di guardare alle circostanze in cui ci si trova, e che quelle prospettive possono aprire uno spiraglio rispetto ad una realtà in cui ci si sentiva isolati e da cui era impossibile sopportare o fuggire.
Il metodo di lettura condivisa ideato da Jane Davis per l’Organizzazione dei lettori ha lo scopo di portare questi temi sul tavolo attorno al quale opera la lettura condivisa: è un tavolo (ben apparecchiato, con caffè e tè e qualche biscotto) dove in media circa otto persone, che non necessariamente si conoscono, si incontrano per leggere collettivamente un racconto e una poesia selezionati per l’occasione da una persona chiamata Reader Leader, che ha il compito di leggere ad alta voce agli altri membri il testo (che viene consegnato a ogni partecipante durante l’incontro, quindi non viene distribuito in anticipo, il che significa che i partecipanti non possono leggerlo prima). Il Reader Leader ha anche il compito di facilitare una conversazione sui testi e intorno ad essi, una conversazione che non deve portare alla “giusta” interpretazione dei testi, ma piuttosto alla condivisione di prospettive su di essi, prospettive che ruotano intorno alla questione di come i lettori si relazionano con il testo ma anche tra di loro: le intuizioni che derivano da queste conversazioni sono pensate per essere differenziali e correlate allo stesso tempo.
La lettura condivisa ha lo scopo di creare connessioni tra i partecipanti che, partendo dal testo e tornandovi a intervalli regolari, parlano della propria vita, delle proprie esperienze e del proprio background in relazione ai temi sollevati dal testo. Queste esperienze sono a loro volta arricchite dalle somiglianze e dalle differenze con le esperienze che gli altri membri del gruppo possono esprimere in risposta al testo e a ciò che gli altri sono ispirati a dire su di esso. Di tanto in tanto, nel corso della lettura del testo, il Reader Leader si ferma e invita i partecipanti a rispondere a domande aperte che sono radicate nel testo: Come vi siete sentiti in questo passaggio specifico? Cosa vi ricorda? Come vi sentite rispetto a ciò che questo personaggio sta dicendo o facendo? Vi siete trovati in circostanze simili? Cosa fareste se foste nei panni di questo personaggio? Il metodo non cerca una discussione sulle tecniche di scrittura o approfondimenti narratologici, né informazioni sull’autore del testo o sulla specifica tradizione o scuola di provenienza. Il metodo è rivolto alle esperienze dei lettori, al plurale, in relazione al testo e agli altri lettori: l’idea è che discutere la propria esperienza in presenza di altri arricchisca quell’esperienza e approfondisca la comprensione, non solo del testo che si sta leggendo insieme, ma anche del rapporto con gli altri e, forse soprattutto, con sé stessi.
Il metodo della lettura condivisa viene utilizzato ed è stato sperimentato in diverse circostanze con diversi gruppi di partecipanti: in strutture di salute mentale, nelle carceri, nelle scuole, negli istituti per anziani, compresa la possibilità di progettare sessioni specifiche per i partecipanti affetti da demenza. I contesti possono essere diversi, ma ciò che accade in essi, idealmente (e ho avuto l’esperienza di testimoniarlo in molti dei contesti sopra citati, sia come partecipante che come Reader Leader) è molto simile: parlando di specifici passaggi dei testi, in generale di ciò che i personaggi di questi testi fanno (o non fanno) e pensano o dicono (o non pensano e non dicono) i partecipanti iniziano a parlare di come vedono queste cose, idealmente non all’unisono: il testo idealmente apre una pluralità di prospettive, invitando ogni partecipante (in un contesto di sicurezza, non di obbligo) a offrire la propria visione. Il testo permette alle diverse prospettive di nascere e le mette in relazione tra loro: ciò che i partecipanti hanno in comune nella pratica della lettura condivisa è il testo e il momento in cui lo scoprono (e scoprono sé stessi) gradualmente.
In che modo questa pratica di lettura può essere vista come una forma di cura? Per cercare di rispondere a questa domanda mi baserò soprattutto sul recente Being Ill (Reaktion, 2025) di Neil Vickers e Derek Bolton. Gli autori sono colleghi del King’s College London’s Centre for the Humanities and Health, dove Neil Vickers (precedentemente epidemiologo) è professore di letteratura con un interesse specifico per le questioni mediche e Derek Bolton professore di filosofia e psicopatologia (da poco in pensione), che lavora anche come psicologo clinico presso l’Institute of Psychiatry e il Maudsley Hospital di Londra.
Il messaggio centrale del libro è già contenuto nel suo sottotitolo: Malattia, cura e abbandono. Quando siamo vittime di una malattia importante, sia essa mentale o corporea, sostengono gli autori, ci aspetta uno dei due esiti possibili: essere curati o essere lasciati soli – in entrambi i casi da coloro che sentiamo vicini. La cura è l’argomento centrale del secondo capitolo (e a mio avviso il più forte) di Being Ill. Per Vickers e Bolton, la cura comporta tre aspetti principali: il rispecchiarsi, l’accoglienza e la compassione. Vorrei provare a chiarire come la lettura della letteratura, in particolare nel contesto del formato della lettura condivisa, possa essere collegata a questi aspetti.
Il rispecchiarsi, il primo dei concetti di Vickers e Bolton, si riferisce a ciò che gli autori di Being Ill definiscono come un “insieme di processi attraverso i quali due persone indicano la loro consapevolezza reciproca” (77). Il concetto è tratto dall’ambito della ricerca sull’infanzia, dove il rispecchiarsi si riferisce alla pratica di definizione reciproca di madri e bambini. I neonati rispecchiano ciò che le loro figure di riferimento mostrano loro, in un complesso gioco di attività corporee e mentali che sottolineano contemporaneamente la dipendenza del bambino dalla madre e la sua capacità di crescere verso l’indipendenza. Questa idea di base è anche alla base, secondo Vickers e Bolton, del concetto di cura nel mondo degli adulti: una comprensione produttiva di ciò che la cura è e fa, secondo loro, non dovrebbe enfatizzare eccessivamente l’impotenza di base della persona assistita, ma essere attenta a salvaguardare per questa persona risorse di autonomia e, quindi, la possibilità di auto-cura. Prendersi cura di qualcuno, in altre parole, significa anche permettere a quella persona di sviluppare, mantenere o rafforzare la possibilità di autocura. E questo è ciò che la SR fa o almeno si propone di fare; in questo senso la pratica è una pratica di cura.
Gli studiosi di letteratura tendono a mettere in relazione il concetto del rispecchiarsi con un’analisi cognitiva del processo di lettura: il riferimento immediato sarebbe quindi ai neuroni specchio e a come la loro attività sia alla base di quella che i cognitivisti chiamano la nostra “teoria della mente”, la capacità degli esseri umani di attribuire stati mentali ad altri esseri. Il lavoro di Lisa Zunshine è dedicato principalmente alla questione di come la lettura della letteratura influenzi questa capacità, offrendo eventualmente ai lettori l’opportunità di allenare questa capacità e di diventare migliori lettori della mente nella vita reale.
Sembra logico che l’approccio alla teoria della mente negli studi letterari prenda spesso come punto centrale di attenzione la rappresentazione dei personaggi di fantasia, i loro stati d’animo, ma anche il loro comportamento e la possibilità che da questo comportamento si possa dedurre (a torto o a ragione) il loro stato d’animo. Questo è anche ciò che accade nella pratica della lettura condivisa: le discussioni tra i partecipanti si concentrano spesso su ciò che i personaggi fanno, pensano o sentono (e sugli inevitabili collegamenti tra questi), ma anche sulla questione di ciò che i lettori stessi farebbero se si trovassero in circostanze simili; i partecipanti si mettono nei panni dei personaggi, per così dire, e così facendo non solo arrivano a una nuova comprensione di questi personaggi, ma anche di loro stessi.
Inoltre, il processo del rispecchiarsi, in questo formato specifico, non si limita all’interazione tra il personaggio di finzione e il singolo lettore: ascoltandosi a vicenda e assistendo alle risposte corporee e di altro tipo di altri lettori allo stesso testo, i partecipanti si rispecchiano a vicenda. L’effetto di questo processo specifico è, da un lato, la comprensione di come gli altri interpretano il testo, spesso in modo diverso, ma anche una comprensione differenziale della propria prospettiva, che nasce in relazione a quella degli altri.
Anche il secondo “pilastro” della cura di Vickers e Bolton, l'”holding”, deriva dal campo della psicologia infantile dello sviluppo, in particolare dalle ripetute riflessioni di Donald Winnicott su questo concetto. Come nelle loro riflessioni sul rispecchiarsi, Vickers e Bolton sostengono la possibilità di applicare questa teoria in generale alle relazioni con gli adulti e, nel particolare, alle relazioni di cura con le persone malate. In situazioni di malattia, scrivono, l’importanza dell'”holding” si manifesta chiaramente, non solo nella necessità di trovare un buon “ambiente di holding” (il termine di Winnicott per indicare il rifugio sicuro in cui la cura può svolgere il suo lavoro anche inosservata), ma anche nell’importanza delle pratiche di “partecipazione creativa” (69) (ciò che Winnicott definiva “gioco”) che consentono ai caregiver e alle persone di cui si prendono cura di stabilire e mantenere relazioni significative. Per Winnicott, la pratica dell’holding ha lo scopo di permettere ai bambini di prosperare; anche se la parola può suonare strana nel contesto di casi gravi di malattia, questo è esattamente ciò che Vickers e Bolton vorrebbero vedere fare ai pazienti e alle persone di cui ci prendiamo cura.
La nozione di Winnicott di “ambiente di sostegno” è interessante per descrivere ciò che fanno i gruppi di lettura condivisa: questi gruppi sono idealmente spazi sicuri, spazi in cui i partecipanti si sentono incoraggiati (e non costretti) a dire ciò che vogliono dire, sia in risposta al testo che viene letto sia ai commenti dei compagni di lettura. I passaggi specifici del testo e le domande che il Reader Leader ne trae fungono da spunti, ma non nel senso direttivo del termine: invitano a una risposta parlata (pur consentendo la possibilità di una risposta silenziosa) che non riguarda la corretta comprensione di questo o quel dettaglio del testo, ma ciò che fa venire in mente a ogni singolo lettore.
Se si può dire che il gruppo di lettura funziona come un ambiente di sostegno in cui queste riflessioni possono essere condivise in modo sicuro, lo stesso vale, in modo importante, per il testo stesso. Nella teoria di Winnicott, l’attività di holding (nel caso dei neonati da parte della figura materna) è un’attività di sostegno (e quindi di dipendenza) che ha lo scopo di portare allo sviluppo di una maggiore autonomia (e quindi di indipendenza), e in un certo senso è così che funziona anche il testo nel formato della lettura condivisa: sostiene (“trattiene”) le diverse interpretazioni e riflessioni che ispira nei diversi lettori e le tiene insieme, nella loro diversità e nella loro differenza. Il testo, in altre parole, è un oggetto là fuori, che esiste a prescindere dalle diverse interpretazioni e riflessioni dei partecipanti: non può essere ridotto a una singola risposta. Inoltre, come confermano diversi partecipanti con cui ho parlato degli effetti della lettura condivisa, senza i testi le conversazioni non avrebbero luogo.
In quanto tali, come ho scritto altrove, i testi letterari (testi di finzione) funzionano come quelli che Winnicott chiama “oggetti transizionali”: consentono un processo di sviluppo che permette ai lettori di arrivare a un’interpretazione del testo che possono vedere come del tutto propria, mentre allo stesso tempo arrivano a comprendere che il testo esiste a prescindere da questa interpretazione e che, quindi, altri lettori possono interpretarlo in modo diverso. I testi, nella loro capacità di oggetti transizionali, non sono ciò che Winnicott chiama “entità proiettive”: non coincidono semplicemente con l’uso che ne facciamo, ma permettono un uso diverso anche da parte di altri lettori.
La “compassione”, terzo pilastro concettuale della cura secondo Vickers e Bolton, è una qualità spesso collegata alla lettura di scritti letterari. Molti studiosi cognitivi della letteratura hanno sostenuto il potere della letteratura nel promuovere l’empatia, e gli operatori della lettura condivisa (sia i Reader Leaders che i partecipanti) avranno molti esempi che lo confermano. La pratica collettiva non solo stimola la nostra empatia con i personaggi di fantasia, in quanto cerchiamo di immaginare ciò che pensano e sentono, ma anche con i nostri compagni di lettura nel gruppo. Condividendo i nostri pensieri sui testi che leggiamo, ci prendiamo cura dei testi, dell’altro e di noi stessi.
Jürgen Pieters – Professore di teoria letteraria presso il Dipartimento di Studi Letterari dell’Università di Ghent