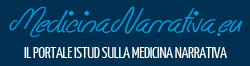A Gaza i civili e chiunque tenti di prestare aiuto – medici, infermieri, soccorritori e giornalisti – sono diventati bersagli cercati.
È prassi la trappola mortale del double-tap e la paralisi del soccorso: questo fenomeno – in cui un secondo bombardamento colpisce lo stesso obiettivo poco dopo il primo, proprio mentre i soccorritori e i giornalisti accorrono – è documentato da almeno 24 episodi dopo il 7 ottobre 2023. Questa pratica moltiplica le vittime, annullando l’efficacia negli aiuti e ha un effetto psicologico paralizzante: rende ogni operazione di salvataggio un potenziale atto suicida, e crea un dilemma etico insormontabile tra dovere umanitario e istinto di sopravvivenza (quello che sta accadendo in questi giorni con la Flotilla).
Si diffonde la narrazione del martire: in questo contesto oltre alla guerra fisica si è affermato un pericoloso conflitto narrativo. I soccorritori e gli operatori sanitari uccisi vengono sistematicamente etichettati non come civili neutrali, ma come “martiri” o “simpatizzanti” di gruppi armati: questa retorica, che equipara l’atto umanitario al sostegno al terrorismo, trasforma un medico che estrae un bambino dalle macerie in un legittimo obiettivo militare. È una strategia che cerca di delegittimare le vittime e giustificare giuridicamente attacchi che altrimenti apparirebbero come chiare violazioni del diritto internazionale e di dare il via libera e liberare le coscienze dei militari che uccidono i professionisti dell’aiuto: la guerra non si fa solo con le armi ma anche con la propaganda influenzante dei significati che si danno ai gesti.
I numeri sono disarmanti: il Ministero della Salute di Gaza stima oltre 1.500 vittime tra medici, infermieri e soccorritori. Anche i dati dell’OMS parlano di 680 operatori sanitari uccisi. Ogni vita perduta è un colpo mortale a un sistema sanitario già in agonia, dove il 94% degli ospedali risulta danneggiato o distrutto e si contano oltre 1.900 episodi di attacchi alla sanità.
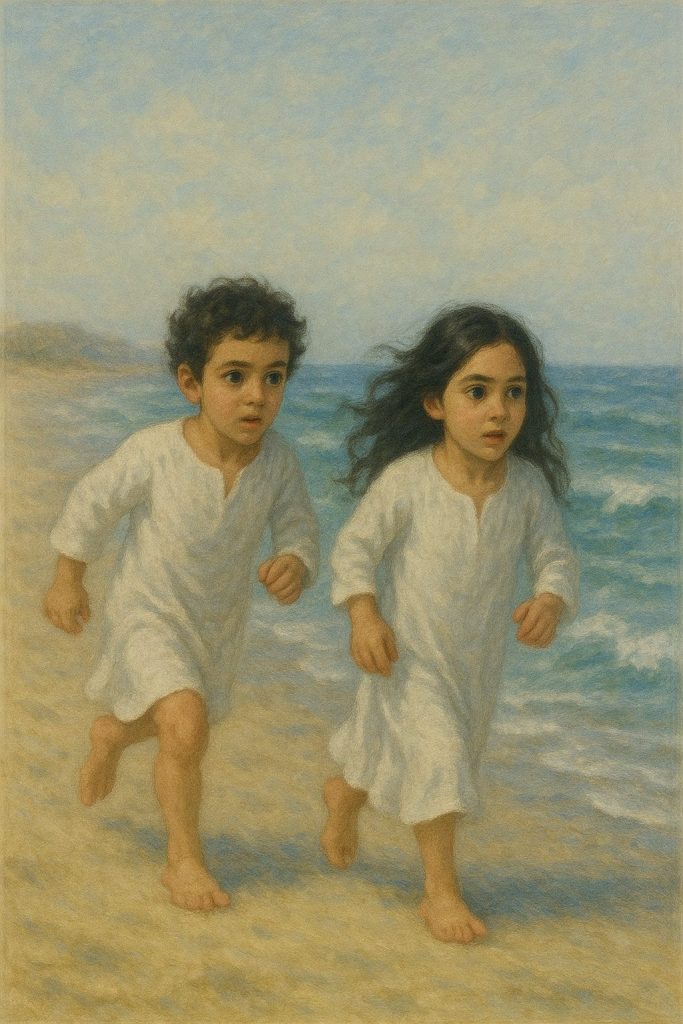
La testimonianza che rinasce nonostante il silenzio
Anche se 237 giornalisti sono stati uccisi, sopprimendo la testimonianza diretta, la verità trova strade alternative. Il film “La voce di Hind Rajab“, premiato con il Leone d’Argento a Venezia, diventa il grido di una bambina rimasta intrappolata tra le macerie, dando voce a chi rischierebbe di rimanere invisibile dietro i numeri. Quando i testimoni oculari vengono eliminati, è l’arte a farsi carico della memoria, trasformando la statistica in un’esperienza umana con cui tutti possiamo identificarci.
In questo scenario, ciò che viene attaccato non è solo un territorio, ma il concetto stesso di umanità. Le Convenzioni di Ginevra nacquero per dare un limite alla crudeltà della guerra. A Gaza, quel limite è stato oltrepassato, ma la testimonianza, in tutte le sue forme, continua a lottare per riaffermarlo. Eppure, quella realtà supera ogni possibile immaginazione per noi a distanza in un paese dove i civili sono vicini con l’anima e quasi la totalità del nostro servizio sanitario nazionale sostiene la causa della popolazione. Non a caso sono stati loro a promuovere la giornata del digiuno in Italia, come simbolo della fame con cui viene debilitata la popolazione di Gaza da non poter muoversi e mobilitarsi, per andare dove, poi? La “fuga” significa spostarsi dentro la Striscia, non uscirne. Non ci sono corridoi di uscita aperti al pubblico: i valichi verso Israele sono chiusi ai palestinesi e la via verso l’Egitto è chiusa o con accessi estremamente ristretti. Le agenzie ONU continuano a dire che “non c’è alcun luogo sicuro” all’interno di Gaza, ma gli spostamenti forzati vengono comunque ordinati verso aree designate a sud e lungo la costa. Verso il nulla, o verso organizzazioni umanitarie oggetto di continuo double tap.
Sento il dovere di scrivere queste righe perché ho scoperto che molti di noi non conoscono la strategia del double tap: a me ha impressionato, a Gaza non sono stati gli israeliani i primi a usarla ma nasce ed è stata documentata nei paesi come Siria, Yemen, Afghanistan, Pakistan…
E in passato?
C’è stato, seppure tra violente eccezioni, un codice d’onore. E qui, a Gaza, quel codice è stato abbandonato.
Ma guardiamo al passato. In tutte le guerre, da sempre, i codici d’onore non erano solo un insieme di regole per limitare la violenza: erano narrazioni condivise che trasformavano i gesti in simboli. Nel Medioevo, il codice della cavalleria prescriveva che un cavaliere risparmiasse il nemico disarmato; in quell’atto, egli non compiva una semplice azione pratica, ma forgiava la leggenda di sé come uomo d’onore. Nella cultura bushido, un samurai che mostrava pietà verso un avversario vulnerabile non era debole, ma incarnava la suprema narrazione di una disciplina che separa la forza dalla crudeltà.
In questi esempi, non è l’atto in sé a parlare, ma il significato che la comunità gli conferisce attraverso il racconto. È la storia, infatti, a decretare se un valore è “buono” o “cattivo”.
Se i valori veicolati dalla narrazione sono giusti, il gesto diventa un segno di umanità; se i valori sono distorti, lo stesso gesto viene trasformato in mostruosità. La narrazione, quindi, non si limita a descrivere la realtà: ne genera attivamente il significato etico.
In questo senso, le Convenzioni di Ginevra non hanno fatto altro che codificare ciò che l’etica di culture diverse aveva già intuito: il senso della guerra non è lasciato all’istinto bruto, ma dipende dalla cornice di significato che attribuisce valore alle azioni: quando il soccorso è raccontato come un atto di umanità, chi cura una persona ferita rischiando la vita è un eroe; quando è narrato come complicità con il nemico, quella stessa azione diventa un pretesto per ammazzare sapientemente con double tap.
Le convenzioni hanno messo nero su bianco questa consapevolezza profonda: i valori narrati collettivamente sono il fondamento stesso dell’Humanitas.
Ecco perché i crimini di guerra non sono solo violazioni di un trattato: sono la riaffermazione di quei ‘disvalori’—la crudeltà, il disprezzo per l’innocente, l’abolizione di ogni limite—che ogni codice d’onore, da quello cavalleresco, a quello bushido in Giappone, a quello islamico (non colpire donne e bambini) era nato per bandire. Sono la mostruosità elevata a sistema.”
Maria Giulia Marini