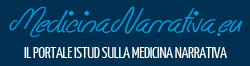Quando pensiamo alle storie, tendiamo a dividerle in due grandi categorie. Da una parte ci sono quelle inventate: romanzi, racconti, fiabe. Dall’altra, quelle che si attengono ai fatti: biografie, testimonianze, cronache. Ma quando entriamo nel campo della medicina narrativa, questa distinzione diventa meno netta. I racconti di malattia si muovono in uno spazio intermedio, dove convivono due registri complementari: la true narrative e il fictional storytelling. Entrambi sono autentici, ed entrambi necessari per comprendere davvero l’esperienza della malattia.

La true narrative è quella che si avvicina di più al resoconto cronachistico. Il paziente racconta date, luoghi, diagnosi, cure: “Il 5 marzo mi hanno ricoverato, dopo tre giorni mi hanno diagnosticato una leucemia. Ho iniziato la chemioterapia il 12 marzo”. Questa modalità ha un valore importante: mette ordine, ricostruisce la sequenza degli eventi, rende possibile per i professionisti cogliere la traiettoria clinica. È la verità oggettiva dei fatti.
Accanto a questo registro, però, si sviluppa quasi sempre il fictional storytelling. Non significa inventare, ma usare immagini, metafore e simboli per dire l’esperienza interiore. In un progetto di ricerca di Medicina Narrativa sul dolore a 360 gradi emergono con forza queste dimensioni immaginative. Una persona ha scritto: “Mi sentivo come un Cristo in croce, con i chiodi che trafiggevano il mio corpo”. Un’altra persona ha descritto la sua malattia come “un’ombra scura che si allungava su di me, silenziosa ma costante, sottraendomi lentamente la forza e la luce”. Altri ancora hanno parlato di “una stanza senza finestre”, di “un genitore stressante”, di un “gatto castrato” o di un “mostro”.
Queste immagini non raccontano i fatti, ma restituiscono una verità emotiva, esistenziale e relazionale. Permettono di descrivere il dolore, la paura, ma anche ciò che spesso sfugge ai linguaggi clinici: i desideri interrotti, i sogni che si allontanano, le perdite di identità e di possibilità. Una persona con depressione ha scritto: “Mi pesa aver perso 20 anni della mia sessualità, mi pesa che qualcuno abbia abusato del mio corpo, mi pesa non poter fare alcune attività che prima facevo abitualmente”. In un’altra narrazione emerge la nostalgia per ciò che non sarà più possibile: “Mi pesa non poter fare paracadutismo”.
La medicina narrativa mostra che non esiste gerarchia tra queste due modalità. La true narrative dà chiarezza e ordine. Il fictional storytelling porta profondità, colore, emozione, e racconta non solo ciò che si è provato, ma anche ciò che si è perduto o che si sperava di avere. Una frase può iniziare come true narrative – “Oggi ho fatto il controllo in ospedale, i valori erano stabili” – e trasformarsi subito in storytelling: “Mi sentivo però come un equilibrista su un filo sottile: bastava un passo falso e sarei caduto di nuovo nel vuoto”.
Per le persone, avere accesso a entrambe le modalità ha un valore terapeutico. La true narrative permette di orientarsi in un percorso spesso frammentato. Il fictional storytelling rende comunicabile la paura, la rabbia, la speranza, ma anche l’immaginazione di un futuro diverso.
Per i professionisti della salute, saper leggere entrambi i registri significa entrare in un ascolto più profondo. La true narrative offre informazioni cliniche indispensabili, il fictional storytelling rivela l’impatto sulla vita quotidiana, sulle relazioni, sull’identità. Un medico che ascolta entrambe non raccoglie solo dati: entra in contatto con l’esperienza vissuta.
La tentazione potrebbe essere quella di distinguere rigidamente: la true narrative sarebbe “vera”, il fictional storytelling “falso”. Ma la realtà è più complessa: entrambi sono veri, ciascuno a modo suo. La prima racconta i fatti, il secondo racconta come quei fatti sono stati vissuti. Insieme compongono una verità più ampia.
Le storie di malattia si collocano quindi su un continuum tra cronaca e simbolo, tra realtà e immaginazione. Non si tratta di scegliere, ma di abitare quello spazio intermedio dove la vita si racconta nella sua interezza. In fondo, non c’è narrazione più vera di quella che unisce i fatti e le emozioni, le perdite e i desideri, la memoria e i sogni. La medicina narrativa lo sa bene: il racconto della malattia non è mai un documento freddo, né una fantasia evasiva. È un ponte, fatto di realtà e immaginazione, che ci permette di comprendere e prenderci cura.
Beatrice Rampinini – Ricercatore Area Sanità e Salute ISTUD