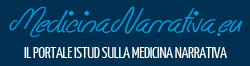Commento di Maria Giulia Marini
Epidemiologa e Counselor
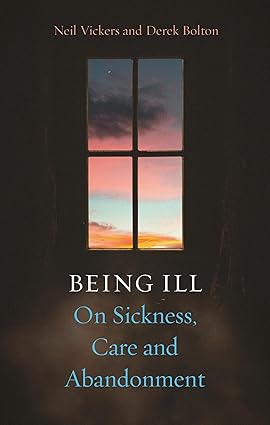
“Being Ill” di Neil Vickers e del professor Derek Bolton del King’s College di Londra è una lettura imperdibile, un capolavoro potente e interdisciplinare. Questo libro intreccia magnificamente l’epidemiologia, le più attuali teorie neuroscientifiche e psicologiche e la filosofia della medicina narrativa per esplorare cosa significa veramente ammalarsi, non solo fisicamente, ma anche emotivamente, socialmente ed esistenzialmente.
Offre una critica cruciale alle società WEIRD (Western, Educated, Individualistic, Rich, and Democratic – Occidentali, Istruite, Individualiste, Ricche e Democratiche), che, avendo favorito quella che Zygmunt Bauman ha definito una società liquida, spesso allontanano la malattia dalla vista. In queste culture, i malati sono visti come perturbatori di un ideale di autonomia, efficienza e controllo. C’è un profondo disagio nei confronti della vulnerabilità e, di conseguenza, gli individui malati sono spesso emarginati o evitati.
Al contrario, le società Mediterranee danno ancora valore alla vicinanza relazionale, dove le reti familiari e amicali forniscono importanti spazi sicuri per chi soffre. In queste culture, la malattia non è vista come qualcosa di vergognoso o privato, ma come un’esperienza condivisa, da portare avanti insieme. Questo confronto è essenziale per ripensare al modo in cui possiamo umanizzare le cure e resistere agli effetti isolanti dell’individualismo.
La struttura del libro è ben progettata e intellettualmente generosa. I suoi capitoli chiave – La Malattia Emergente, La Cura, La Sindrome del Pariah (una potente riflessione sullo stigma e la discriminazione) e Gli Esseri Biopsicosociali – offrono ciascuno una prospettiva fresca e interdisciplinare. Gli autori si spingono oltre il modello biomedico, mostrando come la malattia sia un destabilizzatore del nostro equilibrio interiore, qualcosa che sconvolge non solo il corpo, ma anche le nostre identità e i nostri ricordi ed entra nella nostra vita come un problema, paralizzando un intero sistema. Quando la malattia colpisce, scuote le fondamenta di ciò che consideriamo normale – e questo disagio è avvertito non solo dalla persona malata, ma da tutti coloro che la circondano e che potrebbero rifiutare o accettare i problemi creati dalla malattia.
Il capitolo La cura è particolarmente illuminante. Spiega che il processo di cura si svolge in una progressione in tre fasi: la prima è “care about”, che significa diventare consapevoli della sofferenza di un altro e riconoscerla come importante; poi la “care for”, che significa accettare la responsabilità di rispondere a quel bisogno; infine, il “caregiving”, che è l’atto concreto di aiutare. Questa struttura è perfettamente parallela alle fasi della Comunicazione Nonviolenta (NVC): innanzitutto, distinguere il bisogno che sta alla base dell’esperienza; poi, ascoltare profondamente la narrazione del paziente; infine, offrire un’assistenza in grado di sostenere una trasformazione da una narrazione vecchia, spesso dolorosa, a una nuova, potenziante. Questa riformulazione – attraverso l’empatia, la presenza attenta e la responsabilità morale – è ciò che rende la cura non solo un’azione tecnica, ma una “buona” relazione.
Vickers e Bolton propongono anche un triplice processo di risposta alla malattia: il rispecchiamento – sperimentiamo l’empatia vedendo noi stessi nell’altro, l’accoglienza – creiamo il legame, uno spazio sicuro e compassionevole che riconosce la vulnerabilità, e la compassione – agiamo con cura, facendo qualcosa di significativo per la persona malata.
Questo processo, anche se discusso in un contesto clinico e psicologico, è profondamente radicato nella nostra evoluzione biologica e relazionale, in particolare nella relazione madre-bambino, una delle forme più ancestrali di cura. È attraverso questi schemi primordiali che impariamo a co-regolare, lenire e connettere. Questo processo attiva anche le risposte neurochimiche – serotonina, ossitocina e dopamina – creando un campo intersoggettivo di benessere che nutre sia il caregiver sia la persona assistita.
Un capitolo particolarmente toccante esplora il modello biopsicosociale attraverso una lente epidemiologica, mostrando come i determinanti sociali della salute, come la povertà, la disoccupazione, l’esclusione o la discriminazione, abbiano conseguenze misurabili e profondamente incarnate. Ignorare queste storie riduce la salute alla sola biologia e rafforza un modello bio-riduzionista che è inadeguato e stigmatizzante.
Applicando questi schemi, possiamo passare da un’assistenza sanitaria standard scadente a modelli di cura relazionali e sostenibili. Quando ascoltiamo profondamente le storie dei malati – non solo con competenza clinica, ma con vera presenza, capacità narrativa ed empatia – onoriamo la complessità della loro esperienza e possiamo aiutarli.
La Comunicazione Non Violenta ci insegna a identificare i bisogni sottostanti, ad ascoltare senza giudicare e a rispondere con attenzione piuttosto che con controllo. La medicina narrativa offre ai pazienti una struttura per rimodellare le loro storie – spesso dal dolore e dal caos originario – in ricerca e significato. Quando vengono combinati, come nel mio attuale lavoro di ricerca, questi approcci permettono sia al paziente che all’operatore di impegnarsi in un dialogo trasformativo che costruisce fiducia, sicurezza emotiva ed eventualmente benessere.
“Being Ill” è un appello: sfida gli operatori sanitari e i professionisti dell’aiuto ad andare oltre le soluzioni tecniche. Ci chiede di accompagnare la persona malata e chi la assiste per essere solidali con la sua sofferenza e per creare spazi relazionali sicuri dove possano emergere nuove narrazioni di significato. La malattia è davvero un problema, ma se affrontata con presenza, connessione e compassione, può diventare un’esperienza esistenziale profondamente umana.
Grazie a Neil Vickers e Derek Bolton che con questo libro ci insegnano a essere migliori assistenti.