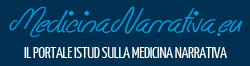Negli ultimi mesi, non si parla più solo di confini da difendere o di eserciti da potenziare: la guerra, o meglio la possibilità concreta di un conflitto sul suolo europeo, entra oggi anche negli ospedali. In Francia, Germania e, più lentamente, anche in Italia, si sta delineando una nuova realtà: quella di una sanità civile chiamata a prepararsi alla gestione di feriti di guerra in modo da garantire una risposta sanitaria in caso di conflitto armato.
Si tratta di una trasformazione silenziosa che attraversa reparti, uffici amministrativi, corsi di aggiornamento e piani strategici. È una preparazione che non si vede, che non fa rumore, ma che racconta molto del tempo in cui viviamo.

FRANCIA: la circolare che cambia paradigma
Il segnale più concreto di questo cambiamento è arrivato dalla Francia, dove il 18 luglio 2025 il Ministero della Salute francese ha inviato una circolare ufficiale a tutte le agenzie sanitarie regionali. Il documento chiede a tutti gli ospedali, sia civili che militari, di organizzarsi per essere pronti, entro marzo 2026, ad accogliere fino a 15.000 soldati feriti in caso di guerra. Si prevedono picchi operativi di 100 pazienti al giorno per 60 giorni di fila, e punte fino a 250 feriti al giorno per almeno tre giorni consecutivi.
Non basta aumentare letti: si parla di centri di smistamento in aeroporti, porti, stazioni, nodi logistici di prima accoglienza, e di percorsi per stabilizzare, smistare o rimpatriare i feriti. Il personale sanitario dovrà essere formato per affrontare situazioni molto diverse da quelle quotidiane: ferite da esplosione, traumi multipli, gestione del sangue, ma anche supporto psicologico per chi ha vissuto esperienze di guerra.
Ma già oggi emergono preoccupazioni: come garantire le cure ordinarie se risorse e personale vengono dirottati sull’emergenza? La carenza di personale nella sanità francese è già un problema grave. Dal governo si insiste che prepararsi ora è meno rischioso che restare impreparati di fronte a una crisi improvvisa: l’esperienza della pandemia lo ha insegnato in modo clamoroso.
GERMANIA: Berlino come hub sanitario in tempo di guerra
In Germania l’approccio non è meno concreto. A Berlino è stato presentato un piano quadro nazionale per la difesa civile degli ospedali, che chiede strutture pronte ad accogliere fino a 100 feriti al giorno pur mantenendo i servizi essenziali per la popolazione civile.
Si stanno creando percorsi d’emergenza accelerati, sviluppando formazione specialistica per gestire traumi da esplosione, amputazioni e politraumi, e rendendo alcuni reparti ospedalieri adattabili a condizioni critiche. Berlino è pensata come hub sanitario della NATO: nodo strategico per smistare feriti non solo internamente ma anche per venire in aiuto di paesi alleati, fungendo da snodo logistico internazionale.
Il piano tedesco mostra una chiarezza operativa forte, ma anche qui i dubbi non mancano: come si stabiliranno le priorità quando il numero dei feriti supera le capacità operative? Chi verrà curato per primo? E come preservare la salute mentale del personale chiamato a operare in scenari traumatici?
ITALIA: tra strategia normativa e ambiguità operativa
Anche l’Italia si sta muovendo, ma con passi più lenti e prudenti rispetto a Francia e Germania. Il Ministero della Salute ha avviato una Strategia nazionale per la resilienza delle strutture critiche, in attuazione della direttiva europea 2022/2557, che include la sanità tra i settori strategici da preparare a scenari di crisi intensi.
È stato istituito un tavolo tecnico interministeriale che coinvolge Salute, Difesa, Infrastrutture e altri enti, con l’obiettivo di definire ruoli e linee guida nel caso di emergenze di vasta portata, compresa un’eventuale guerra. Si stanno avviando esercitazioni congiunte tra ospedali civili e Forze Armate, si stanno individuando i reparti più “critici” da potenziare, e si lavora alla definizione di protocolli condivisi per la gestione dei feriti, dal triage alle evacuazioni.
Tuttavia, molti elementi non sono ancora chiari: l’Italia non ha reso pubblico un dato ufficiale su quanti feriti potrebbe gestire, né ha definito quali ospedali diventeranno centri di riferimento in caso di conflitto. E la domanda cruciale resta: come finanziare formazione specialistica, attrezzature costose e personale aggiuntivo, soprattutto in un sistema sanitario già sotto pressione, con disuguaglianze territoriali e carenze persistenti?
Resilienza umana oltre che tecnica
Numeri e piani sono necessari, ma dietro ogni circolare ministeriale e ogni piano nazionale, ci sono storie invisibili, paure concrete, tensioni personali.
C’è un chirurgo francese che si chiede come farà a gestire 250 feriti in tre giorni, senza abbastanza anestesisti o sale operatorie. C’è un’infermiera a Berlino che si prepara non solo a trattare traumi da esplosione, ma anche a reggere il peso emotivo del caos. C’è un cittadino italiano che, per la prima volta, guarda al suo ospedale chiedendosi se, in caso di guerra, ci sarebbe ancora posto per lui.
È necessario ricordare che ogni ferita è una storia, e ogni piano è una responsabilità che tocca vite. Le scelte cliniche non saranno mai solo tecniche: dovranno tener conto dell’etica, dell’equità, del dolore invisibile.
Ospedali che resistono alla guerra sono una forma di difesa della pace. Ma non basta predisporre letti: servono uomini e donne formati, infrastrutture aggiornate, reti di sostegno emotivo, meccanismi equi di accesso alle cure. Serve una resilienza umana oltre che tecnica.
Prepararsi alla guerra non è una scelta bellicosa – è un atto di tutela. Significa costruire sistemi sanitari in grado di reggere lo shock senza perdere la propria umanità.

FONTI:
- Ospedali convertiti alla guerra, arriva la circolare del Ministero: entro il 2026 previsti 15mila soldati feriti – Giornale La Voce
- “Gli ospedali si preparino all’arrivo di soldati feriti”: la circolare in Francia e lo scenario di guerra
- Il piano italiano per gli ospedali in caso di guerra: «Collaborazione con la Difesa, esercitazioni condivise» – Open
- Ospedali europei si preparano alla guerra: fino a 250 feriti al giorno
- Strategia nazionale sulla resilienza dei soggetti critici
- Italia al lavoro su un piano ospedaliero in caso di guerra
- Francia, Germania e Italia: preparazione ospedali a scenari bellici
- Germania, ospedali in allerta: il piano sanitario di Berlino in caso di guerra – Open