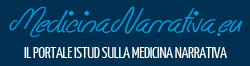Nell’arco dello scorso secolo la scienza medica ha vissuto uno straordinario progresso in ambito diagnostico – terapeutico che ha condotto a una crescente enfasi sulla tecnologia e a una sempre più netta separazione tra cultura scientifica e componente umanistica della medicina.
Con il prevalere della cosiddetta Evidence Based Medicine che si affida a fatti oggettivi, misurabili, quantificabili e generalizzabili si è sempre più trascurato il lato psicologico, emotivo, personale della malattia, si è oscurata la singolarità e unicità sia del paziente che dell’operatore sanitario, entrambi protagonisti della relazione terapeutica (Zannini, 2008). Nella seconda metà del ventesimo secolo si è sentita dunque la necessità di recuperare la porzione umanistica dell’arte medica attraverso le Medical Humanities con l’obiettivo di riportare l’attenzione sull’esperienza umana della malattia e della cura. L’incontro della medicina con le scienze sociali e comportamentali quali sociologia, psicologia, antropologia culturale si è arricchito dell’apporto di arti espressive quali letteratura, musica e arti figurative. Nella mia esperienza di medico il confronto quotidiano con molti colleghi ha purtroppo evidenziato la scarsa consapevolezza degli operatori sanitari circa l’utilità delle arti nel lavoro di aiuto che abbiamo scelto, il quale non si può limitare alla conoscenza dei valori ematici di glicemia o azotemia ma che ci impone di inserire la salute e la malattia nel contesto personale, familiare, sociale del paziente e dunque comprenderne la specificità in un percorso non alternativo ma complementare alla generalizzazione attuata dalla medicina contemporanea. Tale visione olistica sollecita il professionista della salute a rivedere la sua preparazione per poter affinare il cosiddetto “occhio clinico” considerato come la capacità di utilizzare tutti i sensi nel percorso diagnostico (Ferrara, 2020). È quindi opportuno ampliare lo spettro delle conoscenze e abilità degli operatori sanitari, andare oltre la mera competenza tecnica, allenare capacità di comprensione empatica dell’altro e al tempo stesso tenere conto delle emozioni spesso taciute o negate dall’operatore sanitario stesso che sono inevitabili in chiunque affronti la sofferenza e si confronti con il lato notturno della vita.

In che modo sviluppare tali capacità? Le arti figurative, la musica, la letteratura preparano all’incontro con il dolore dell’altro fornendo strumenti emotivi e psicologici necessari all’accoglienza del paziente, strumenti che rendono l’operatore sanitario non solo un professionista “buono”, incontrato per fortuna o casualità, ma un buon professionista in grado di comprendere l’esperienza dolorosa del curato, evitando di esserne travolto. Le arti consentono di sviluppare capacità di osservazione e di interpretazione, di attribuzione di significato all’esperienza di malattia connettendo le emozioni contenute nelle opere artistiche con quelle delle persone assistite e anche con le proprie, utilizzando esperienze personali per meglio comprendere quelle del paziente nella complessità del suo vissuto (Zannini, 2008).
La letteratura è una palestra per sperimentare storie e sentimenti che la professione ci presenterà, non solo il dolore e la sofferenza ma anche l’amore, la nascita e l’allevamento dei figli: chiunque abbia esperienza di ambulatorio o di corsia comprende come la letteratura condivida con la medicina i grandi temi della vita e ci possa dunque preparare a affrontarli, a vivere in anticipo emozioni attraverso il filtro di un libro, facendole decantare in un ambiente protetto.
Al tempo stesso l’esercizio di lettura attenta di un brano, come avviene nei laboratori di Medicina Narrativa sotto la guida di facilitatori di laboratorio formati attraverso uno specifico corso, allena alla comprensione semantica del significato del testo e quindi esercita alla comprensione del “testo orale” che il paziente ci offre nella raccolta dell’anamnesi. Tale esercizio di lettura, oltre a implementare l’ascolto attento e attivo favorendo l’empatia, ci permette di giungere a una più accurata e precisa diagnosi, riverberandosi sul dato tecnico del percorso di cura. Come in modo illuminato scrive Rita Charon “ per fare un buon medico coi vuole un buon lettore” per sottolineare come tale attitudine sia fondamentale per il buon esercizio della nostra professione e non solo in una visione utopistica del medico letterato che si tramanda storicamente. In modo analogo le arti figurative sono utilizzate nei laboratori di Medicina Narrativa per allenare lo spirito di osservazione e l’attenzione per i dettagli: l’osservazione è un elemento basilare nel processo di ricerca scientifica e è fondamentale nella preparazione del personale di cura che attraverso questa capacità diviene maggiormente in grado di valutare le condizioni di un paziente (Ferrara, 2020).
Immaginiamo dunque di osservare un dipinto nei suoi diversi tratti, sfumature e colori così come poi osserveremo il volto, l’andatura, la mimica, lo sguardo di un paziente fin dal suo ingresso nel nostro ambulatorio, consideriamo le tante informazioni che possiamo trarre dall’attenzione consapevole posta sull’espressione non verbale e sul corpo stesso della persona in cerca di aiuto. Inoltre la bellezza, l’intensità, l’espressività di un’opera artistica suscitano in noi emozioni, allenando la nostra capacità di accogliere e tollerare tali sensazioni elaborandole in un luogo neutro rispetto al letto della persona sofferente, permettendoci di conoscere più profondamente noi stessi. Ritengo che osservare con attenzione e emozione la Pietà di Michelangelo o leggere La morte di Ivan Ilic di Tolstoj o ascoltare il Requiem di Verdi possa prepararci al lutto e al conseguente turbamento che induce in noi operatori sanitari, attraverso la visione del volto sofferente di una Madre che cinge un Figlio, attraverso il viaggio nella mente di un uomo vicino alla fine della vita o la potenza sconvolgente di note che descrivono lo sgomento dell’uomo davanti al mistero della trascendenza, con la capacità delle espressioni artistiche di descrivere e sublimare il dolore umano. Le arti ci preparano alle inevitabili emozioni insite nel lavoro che abbiamo intrapreso, sostenendoci nella cura di noi stessi necessaria alla cura dell’altro, rendendoci dunque più resistenti, resilienti, efficaci e efficienti oltre a offrirci attimi di folgorante bellezza. Infine, ultimo ma non meno importante, le arti con il loro contenuto di umanità possono aiutarci a esercitare l’empatia, quella capacità di assumere la prospettiva dell’altro guardando dall’ottica del paziente, di percepire e pensare le emozioni che l’altro sperimenta e anche le nostre emozioni, l’empatia è infatti un comportamento generato da una condizione cognitiva che include abilità di pensiero, attitudini emotive e capacità di distinguere nella relazione il proprio Sé dall’altro con effetti positivi su entrambe le parti della relazione (Ardis, 2022). L’empatia può essere dunque implementata attraverso la frequentazione dell’arte con il suo contenuto di conoscenza e descrizione dell’animo umano, oltre a essere una vocazione dello studente che ha scelto un lavoro di aiuto e che purtroppo recenti studi dimostrano essere addirittura in parte persa nel percorso di studio nella facoltà di medicina. Per tutte le ragioni esposte mi auguro che le Medical Humanities e le arti in modo specifico siano inserite nella formazione del personale sanitario, a vantaggio della relazione con il curato e del benessere del curante.
Raffaella Pajalich, medico chirurgo – Specialista in Endocrinologia e Psicoterapia Cognitiva
Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Medicina Narrativa
Riferimenti bibliografici:
Ardis S., Marcucci M., (2022) Dizionario di Medicina Narrativa, Morcelliana
Charon R., (2019) Medicina Narrativa, Onorare le storie dei pazienti, Raffaello Cortina
Ferrara V., (2020) L’arte come strumento per la formazione in area medica e sanitaria, Aracne.
Zannini L., (2008) Medical Humanities e Medicina Narrativa, Raffaello Cortina