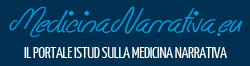«Noi pensiamo di essere eterni, questa è la nostra disgrazia. A scuola non c’insegnano a morire…»
Franco Battiato
Genova Today 23 maggio 2021
Mi voglio avvalere di questa citazione dell’indimenticato maestro Franco Battiato per introdurre questo contributo.
Dal 2016 mi occupo di Cure Palliative domiciliari. La mia non è stata una scelta di pancia, ma una decisione ragionata e maturata dopo ventidue anni di onorato servizio presso strutture ospedaliere pubbliche e private, sempre in ambito intensivo.

Nonostante il percorso che ho fatto sia stato il medesimo di tanti altri colleghi, il passaggio non è così naturale come può sembrare. Se da un lato c’è l’indubbio vantaggio di portare con sé un nutrito bagaglio di conoscenze cliniche, assistenziali e farmacologiche, se si vuole entrare a pieno in quello che sono le cure palliative, è necessario (ed è questa la sfida più ardua, ma anche la più stimolante) operare un pieno e integrale cambio di mentalità. Occorre seppellire definitivamente molte delle proprie convinzioni, ad esempio il fatto che non siamo più noi a decidere ma il paziente e la sua famiglia (in realtà questa dovrebbe essere la regola aurea di ogni professionista della salute in ogni ambito, ma spesso e volentieri ce ne dimentichiamo), oppure che il nostro obbiettivo non è la ricerca di una diagnosi e di una cura, non ci interessa il rapporto causa effetto, non dobbiamo più ricercare il razionale in quello che facciamo, perché di razionale in certi casi e in certe situazioni non c’è proprio niente. E ancora, non dobbiamo più preoccuparci di dare “buone notizie” o peggio, meschine speranze, perché non è di speranza che i pazienti di cure palliative hanno bisogno, e azzarderei a dire che la speranza, in generale, è un concetto da maneggiare con estrema attenzione. Proviamo con un’altra parola, consapevolezza.
Insomma, il pallino passa di mano, per così dire, e ci si trova depotenziati di tutto il nostro arsenale, fatto di autorevolezza, conoscenze, linguaggio tecnico e strumentazioni più o meno avanzate che abbiamo accumulato, autoconvincendoci che il nostro scopo fosse quello di salvare vite. In cure palliative non ci sono vite da salvare… o forse, si?
Siamo passati dall’accogliere all’interno del nostro fortino pieno di strumenti e tecnologie persone disperate, alle quali non siamo rimasti che noi come ultimo baluardo al quale aggrapparsi per tenersi stretta la vita, all’andare a casa di uomini e donne ai quali l’esistenza sta scivolando via come acqua tra le dita, per convincerle a farsi curare… Farsi curare da una malattia per la quale non c’è possibilità di guarire.
Chiedo scusa se la mia descrizione può sembrare troppo enfatizzata, teatrale o faziosa. Niente di tutto questo. Non me ne vogliano coloro (dei quali ho fatto parte fino a dieci anni fa, con pieno orgoglio!) che svolgono il loro dovere con professionalità, impegno, etica e deontologia, nelle unità di terapia intensiva e nei dipartimenti di emergenza. Sono e rimangono fondamentali. Seppur alcuni sciocchi, pensano che oggi sia di moda aggredire i medici e gli infermieri, voglio credere che la parte “sana” della cittadinanza abbia ancora negli occhi quello che si è fatto al tempo della pandemia. Nella risposta al dilagare del COVID – 19, si è vista l’essenza di noi professionisti della salute.
Dicevo, che ho usato toni un poco coloriti, perché penso che la narrazione debba essere un po’ come la filosofia, ossia dotata di un certo grado di provocazione. Mantenendo questo tenore, proseguo affermando che la più consistente scoperta nel passaggio dalla terapia intensiva alle cure palliative è stata che, con i pazienti adesso, mi tocca parlarci! E non solo con loro, anche con i familiari. Non siamo più in ambiente “protetto” dove possiamo esercitare una posizione dominante, o trincerarci dietro a tecnicismi o alla scusa che in quel momento siamo troppo presi. Siamo in casa della gente, dove per quanto autorevoli e competenti, rimaniamo pur sempre “ospiti”. Sportivamente parlando, giochiamo sempre in trasferta.
Proviamo a parlare, dunque. Di cosa parlare rimane un punto dolente, perché nel migliore dei casi ci troviamo davanti a chi sa che gli è rimasto poco da vivere e perciò è profondamento arrabbiato; altrimenti, capita di sentirci dire da coloro che ci apprestiamo ad assistere, che non hanno compreso il motivo per cui siamo lì, e ci chiedono quando potranno riprendere la chemioterapia perché in ospedale, al momento della dimissione, non hanno detto loro nulla di preciso.
A questo punto occorre fare una serie di precisazioni.
Primo: la comunicazione non è arte di tutti. Non è per niente scontato (anche se dovrebbe esserlo), che un professionista sanitario, al netto delle sue competenze specifiche, sia in grado di comunicare in maniera efficace e poco importa se qualcuno afferma che la comunicazione è tempo di cura.
Secondo: parafrasando nuovamente Battiato, esiste un fattore socio–culturale che ha radici antiche e molteplici, fortemente radicato nella nostra civiltà – a mio modesto parere particolarmente in quella occidentale – che si traduce in un curioso paradosso per il quale, a fronte di una risposta razionale e affermativa sul fatto che si è perfettamente coscienti della nostra mortalità, fanno seguito atteggiamenti, comportamenti e gesti totalmente antitetici.
Terzo: al fattore socio-culturale di cui sopra va aggiunta un’altra dimensione, ossia la trasversalità. Questo aspetto caratterizza la società nella sua interezza, e non risparmia nessuno, inclusi gli operatori sanitari. In sintesi, i curanti hanno le stesse fragilità dei curati. E su questo affascinante aspetto tornerò per chiosare.
In situazioni del genere, che le risorse e le competenze tradizionali non siano sufficienti appare quantomeno lapalissiano. Serve altro.
Ho fatto riferimento alle sfide e in particolare a quelle più ardue, cioè a quelle situazioni che ci obbligano ad attingere a tutte le nostre risorse: quelle che abbiamo ben consolidate ma anche quelle che fino a quel momento non consideravamo come tali per finire con quelle che non pensavamo di avere.
Partendo dalle prime, una su tutte per me, è stato rispolverare il concetto di equipe. Più che rispolverare, meglio dire riscoprire, o se si preferisce stare in equipe come veramente bisogna starci, senza gerarchie, senza rimarcare le competenze di ognuno, aderendo scrupolosamente ai propri ruoli e al contempo condividendoli – insieme alle proprie competenze ed esperienze – con gli altri membri, incarnando a pieno il significato di un antico proverbio indiano (Navaho, Apache… non ricordo di preciso) che recita: “ognuno dia per quel che può e prenda per quello che gli serve”.
Per quanto riguarda le seconde, mi riferisco alla fortuna di avere una compagna pedagogista, che mi ha trasmesso concetti come il qui e ora, come lo stare nelle situazioni, più sono difficili e più bisogna saperci stare. Ultimo ma non ultimo, l’allargare e il fare spazio per accogliere dentro di noi tutte le cose, anche le più brutte e lasciarle sedimentare, invece che chiuderci e ostinarci a respingerle. Perché se è vero che una balena è troppo grossa per stare in una vasca da bagno, se la si mette nel mare rimane grossa, ma è molto meno ingombrante.
E per finire con le risorse sconosciute, in questo caso mi è venuta in soccorso la mia più grande passione: la letteratura. Da sempre amo leggere e col tempo ho iniziato ad amare anche la scrittura, fino a farla diventare una professione, che svolgo parallelamente a quella di infermiere, senza dare adito a dualismi o contrasti. Sono entrambe egualmente mie, e a nessuna delle due rinuncio. Va da sé che studio e lettura sono indispensabili per la formazione e per l’aggiornamento; la sorpresa è stata realizzare quanto si può attingere dalla narrativa e dai romanzi di formazione, alla pari dei testi scientifici e di quelli di saggistica. Mi riferisco a pensieri, citazioni, visioni di grandi autori del passato, ma anche contemporanei. Ho trovato una fucina di “nuovi strumenti” per parlare con i pazienti e con le famiglie.
Gli esempi si sprecano. Innegabile, per dirne uno, il contributo che Frankenstein di Mary Shelley e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, danno per comprendere quello che ha poi sintetizzato Battiato e cioè che non ci hanno insegnato a morire e questa è la nostra disgrazia; si pensi a quanto sono stati antesignani Edgar Allan Poe con Il cuore rivelatore e Il barile di Amontillado e Stevenson con Lo strano caso del dottor Jekyll e di mr. Hyde, rispetto alla futura psicanalisi e alla cura delle malattie mentali; e perché non provare ad accostare al concetto di accanimento terapeutico il classico shakespeariano Molto rumore per nulla, e ancora pensiamo alla forza che trasmette Eduardo che in Napoli milionaria scrive “ha da passà ‘a nuttata”, per noi professionisti, quando ci troviamo a fronteggiare un’assistenza particolarmente impegnativa e ancor più per i pazienti, perché la notte passi senza sofferenze o magari perché potrebbe essere l’ultima.
Usare le citazioni, i passi e le metafore delle opere, mi aiuta a semplificare i concetti, ad alleggerire situazioni difficili e a far comprendere le scelte che facciamo. Non si tratta di fare esercizio della lingua o di sfoggiare erudizione. La letteratura e la narrativa sono strumenti potenti, perché sono un serbatoio inesauribile, di parole, concetti, sensazioni, emozioni, e come l’arte in generale appartengono a tutti e da tutti possono essere usate, anche per curarsi e per curare, magari non le malattie, ma le persone.
Non sono in grado di quantificare il peso e l’importanza della letteratura nell’assistenza ai pazienti di cure palliative, né sono in grado di dire con certezza se essa rappresenti un espediente valido in ambito di medicina narrativa, perché mi affaccio a questa realtà per la prima volta con questo mio contributo. Quello che posso affermare, senza dubbio, è che serve a me, per migliorarmi nel mio lavoro.
Certo, parlare di letteratura e di narrativa per uno scrittore, può significare anche “scoprire il fianco”.
Parlare di sé stessi e delle proprie passioni cozza con la massima (o luogo comune?) che dice: privato e lavoro non vanno mischiati, i problemi di casa restano a casa e viceversa quelli del lavoro… Ma è poi così vero? Sul serio si può credere di separare nettamente le due cose? Può sembrare semplicistico quanto sto per affermare ma, non siamo fatti a compartimenti stagni, siamo una miscellanea, ed essere empatici non significa non comprendere i sentimenti e la sofferenza di chi stiamo assistendo, e nemmeno non mostrarsi per quello che siamo: esseri umani, persone, in possesso di abilità e competenze specifiche, ma pur sempre persone, esattamente come quelle che ci stanno di fronte.
Persone, che aiutano persone.
Alessandro Bonet, infermiere case manager Unità di Cure Palliative Domiciliari Life Cure